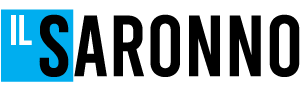Giornata della Memoria, Pietro Bastanzetti e Luigi Caronni: la storia dei deportati saronnesi

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Saronno relativo ai due saronnesi, Pietro Bastanzetti e Luigi Caronni, deportati nei campi di concentramento.
Se si vuole studiare la storia della lotta antifascista nel Nord Italia, un passo nevralgico è costituito dall’ondata di scioperi che si verificò tra il 1943 e il 1945 nei principali centri industriali. Dopo vent’anni di passività i primi segnali di agitazione si ebbero verso la fine del ’42, sotto forma di brevi movimenti limitati a singole fabbriche. Per capire quale fosse il significato di uno sciopero, occorre tener presente che sotto il fascismo lo sciopero era inserito come reato nel codice penale, aggravato se portato avanti in stato di guerra. Particolarmente dure erano le pene previste per i capi e organizzatori dei movimenti di protesta. In questo contesto, lo sciopero assumeva quindi il significato di atto aperto di ribellione e sfida all’autorità, di insubordinazione politica.
Il movimento operaio fu quindi un protagonista della Resistenza non solo per i tanti combattenti che parteciparono effettivamente alla lotta armata, ma anche per l’aiuto fornito da un’azione di massa all’interno delle fabbriche, in buona parte convertite a produzione bellica. Nella nuova ondata della primavera del 1944 il saronnese fu una delle aree geografiche a prendere per prima l’iniziativa. La risposta delle autorità militari non tardò e si abbatté pesantemente sugli
operai, estendendosi anche a sospettati di sentimenti antifascisti: si voleva così dar monito a tutta la popolazione. Vittime di questa attività repressiva furono anche due saronnesi, Pietro Bastanzetti e Luigi Caronni, i cui nomi emergono dalle testimonianze dei sopravvissuti e dalle notizie storiche dell’epoca. Due sono le pietre d’inciampo posate nel 2019 e 2020 in memoria dei cittadini periti nei campi di concentramento.
Qui di seguito illustreremo sinteticamente le loro storie.

Pietro Bastanzetti nato a Vittorio Veneto nel 1901, giunse ancora in fasce a Milano con la famiglia e a 12 anni iniziò a lavorare, portando avanti gli studi serali fino alla scuola media inferiore. Si trasferì a vivere a Saronno negli anni ’30, in virtù del matrimonio con una donna colombarese. Rifiutò sempre di iscriversi al Partito Nazionale Fascista e, durante
il periodo “badogliano”, diede vita, insieme ad altri compagni di lavoro, al primo accenno di democrazia sindacale, la “commissione interna”. Alla Motomeccanica Spa di via Oglio 18, Milano, dove lavorava come capo del reparto “macchinario pesante”, venne scelto dagli operai per rappresentarli. Nel ’43, subito dopo l’Armistizio, e la successiva instaurazione della Repubblica di Salò, l’organismo entrò nella clandestinità e promosse gli scioperi del ’43-’44. La rappresaglia nazi-fascista fu immediata: lo sciopero organizzato nel marzo 1944 infatti scatenò una feroce ondata di violenza portata avanti al fine di soffocare il movimento operaio. Hitler pretese di deportare nei campi di concentramento il 20% degli scioperanti, ma le disposizioni non furono poi attuate del tutto poiché il comando tedesco in Italia, preoccupato di non riuscire effettivamente a controllare un’insurrezione operaia estesa, cercò di mitigare le misure punitive decise dal Fürer. In seguito agli scioperi, i membri della “commissione” di cui faceva parte Pietro Bastanzetti,
vennero denunciati e arrestati.
Ecco il racconto di Giancarlo Bastanzetti in memoria del padre Pietro:
Mio padre lavorava presso la fabbrica “La Motomeccanica” a Milano e durante gli scioperi del marzo 1944, cinque dei sei componenti il “Comitato clandestino d’agitazione” furono arrestati. Fra questi, mio padre fu preso in stabilimento da italiani (fascisti repubblichini) alle 16.10 del 17 marzo e portato nel carcere di San Vittore. Il 20 marzo, assieme ad altri, venne trasferito a Bergamo, presso la caserma del 78° di fanteria “Lupi di Toscana”, dove incontrò Luigi Caronni, saronnese anch’egli, che in occasione di un colloquio con la sorella Gianna le lasciò un biglietto da recapitare a noi. Fu così che venimmo a sapere, finalmente, dove si trovava papà. Potemmo andare a trovarlo più volte e nel corso di uno di questi incontri incontrammo un uomo venuto da Milano a Bergamo in bicicletta, che si offrì di sostituirsi a mio padre, il quale rifiutò dato che in caso di fuga era stata annunciata la “decimazione”. Il 5 aprile 1944 i prigionieri furono caricati su carri bestiame piombati e partirono da Bergamo. Di quegli uomini solo pochissimi sarebbero sopravvissuti alla deportazione; la maggior parte di loro sarebbe diventata fumo nel vento di Europa. Giunsero a Mauthausen l’8 aprile, e vennero subito spogliati di tutto, rasati, disinfettati con creolina, sottoposti a docce, bollenti e ghiacciate, vestiti con pantaloni e casacca zebrata. A ciascuno fu consegnato un numero con un “triangolo rosso” a simboleggiare un deportato
politico. A mio padre fu attribuito il 61562; cessò di essere Pietro Bastanzetti. Dopo 20 giorni di isolamento venne trasferito a Gusen I, uno dei 49 sottocampi di Mauthausen. Qui vene assegnato ad una fabbrica di aerei, la “Messerschmitt”, una delle aziende tedesche che, con la complicità delle Ss, sfruttavano il lavoro dei deportati. La sera del 1° giugno due compagni di baracca, Angelo Caserini e Bruno Bagatta, portano mio padre all’infermeria (“revier”): aveva il viso devastato dai maltrattamenti, la broncopolmonite, la “risipola” (erisipela) e non si reggeva in piedi. Qui non venne accettato, perché, benché febbricitante, non considerato abbastanza grave. La mattina dopo era nel mucchio davanti al forno crematorio. Se ne andò così all’età di 42 anni, Pietro Bastanzetti, sostenitore di giustizia e la libertà. Il suo ritorno fu a lungo atteso invano da tutti noi. Ricevemmo una lettera dal “Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S D in Italien-Gruppe Oberitalien-West” in data 26.8.44 che annunciava: “Gentile signora, siamo spiacenti di comunicarle che suo marito Pietro Bastanzetti, venuto in Germania per motivi di lavoro l’8.4.1944, è purtroppo deceduto in seguito alle ferite riportate durante un attacco aereo terroristico degli Anglo-Americani. La presente dichiarazione serve anche come certificato di morte per le autorità italiane”. Seguì una seconda comunicazione del Comune di Saronno: “Dagli elenchi depositati presso la Questura di Milano mi risulta che il vostro congiunto Bastanzetti Pietro che trovatosi in Germania dall’8.4.1944 internato per misure di Pds è deceduto in seguito a bombardamento il 2.6.44”. A Liberazione avvenuta, con data 6.9.45, dal Ministero Assistenza Postbellica, giunge questa lapidaria comunicazione: “Il
sig. Bastanzetti Pietro risulta nel Registro del Crematorio di Mauthausen in data 3.6.44”. Nel 1964 incontrai Bruno Bagatta che in lacrime mi raccontò come mio padre gli avesse dato due cerini per i suoi figli “come tutto quello che poteva lasciar loro” e lui li avesse poi barattati per una fettina di pane con un russo che aveva una sigaretta, ma nulla con cui accenderla. Non avendo una tomba sulla quale portare un fiore o recitare una preghiera, nel 1961, dalla mia famiglia e altri interessati, fu acquisito il forno crematorio di Gusen ed eretto un memoriale che reca su una parete la foto di mio padre con la scritta “Per la giustizia e la libertà è morto – per la giustizia e la libertà vive”.

Luigi Caronni, nato a Saronno nel 1906, edicolante, di lui erano noti i sentimenti antifascisti, tuttavia non era attivo politicamente, non aveva aderito ad alcun partito, era più semplicemente contrario alla dittatura e alla guerra. Vittima di una denuncia anonima, fu arrestato dalla Guardia Nazionale Repubblicana di Saronno, particolarmente attiva nel coadiuvare le azioni della polizia militare tedesca. Erano infatti circa le 22 di venerdì 3 marzo 1944 quando Luigi Caronni, saronnese di nascita, trentotto anni, edicolante e titolare della agenzia di distribuzione di giornali a Saronno del tempo, si trovava nel retrobottega per preparare la “resa” – la restituzione delle copie invendute -, quando sei individui in divisa della Guardia Nazionale Repubblicana irruppero nel portone dell’allora via Milano 2 (oggi via L. Caronni 2) e lo arrestarono. Non gli fu concesso di avvertire i familiari che si trovavano nell’abitazione sopra il negozio e la sorella Gianna, il mattino successivo trovò la luce accesa e la porta spalancata, il lavoro interrotto e nessuna traccia del fratello.
Luigi fu portato inizialmente al piazzale del Santuario, dove si trovava un autocarro in attesa di altri prigionieri, e poi in seguito al distaccamento della Guardia Nazionale Repubblicana, in via Copernico a Milano. Da qui Caronni venne trasferito al carcere di San Vittore da dove, dopo due settimane di permanenza, giunse a Bergamo, alla caserma del 78° di fanteria e dove incontrò il Bastanzetti.
Qui gli venne affidata la mansione di “spesino”, per cui, sotto l’attenta e armata vigilanza tedesca, usciva ogni giorno per un giro nei negozi ad acquistare, con le tessere annonarie, quanto concesso e disponibile per i compagni di prigionia. Questa suo ruolo suggerì al cognato di Caronni, Luigi Castiglioni, un progetto temerario: si recò in automobile a Bergamo, per il cui uso aveva un permesso dato dalla professione e, una volta iniziato il giro di routine per i negozi, seguì Luigi scortato dal tedesco e al momento opportuno gli suggerì al parente, in dialetto, di fuggire immediatamente e salire sull’auto che l’aspettava; Castiglioni stesso avrebbe provveduto al soldato nazista. Caronni, consapevole che la sua fuga avrebbe causato la fucilazione di altri dieci prigionieri, rifiutò. Arrivò al campo di Mauthausen con “il trasporto” dell’8 aprile 1944, dove venne spogliato del proprio nome e cognome per vedersi assegnato un numero: il 61595. Il 7 maggio successivo fu assegnato al sottocampo di Gusen, per i lavori forzati. Ecco il ritratto di Luigi Caronni nelle parole del pittore Aldo Carpi De Resmini (a Mauthausen matricola 53376), pittore, docente e poi direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera, giunto nel febbraio 1944 e trasferito a Gusen sino alla liberazione):
testimonianza raccolta dal quotidiano La libertà il 27 luglio del 1945:
[Aldo] non sarebbe sopravvissuto agli estenuanti lavori se non fosse stato per chi – «[…] un tal Caronni di Saronno, se non andiamo errati – giornalaio, […]» gli suggeriva qualche accortezza e malizia per poter di qualche momento in più di riposo, lo faceva mettere dietro di sé per “far finta” di lavorare con il badile troppo grosso, per avvisarlo all’arrivo del “capo”.
e ancora Il segno, 28 aprile 1946:
«[…] Era domenica, quando partimmo per Gusen. […]. Noi italiani ci portarono al blocco 31 ed io fui il camerata di Caronni. Alle quattro di mattina sveglia, alle sei partenza per il lavoro: “Steinbruk, la cava delle pietre”. Io stavo già male… lavorai alla cava. […] Sei ore e poi la zuppa, e poi altre sei ore. E le mani si ferivano e si tagliavano, e pioveva, e pioveva. Alla sera si doveva tornare al “Lager”, io non potevo camminare, avevo le ciabatte rotte ai piedi. Caronni mi prendeva sottobraccio, mi tirava e mi sosteneva. […]. Dopo pochi giorni ero già all’ospedale con broncopolmonite. Questa dopo un mese era guarita, ma degli ascessi gravi si formarono nel corpo. Nessuno mi guardava né mi curava. Non vedevo più Caronni da mesi: lo ceravo, domandavo, non lo trovavo più. Un giorno lo scopersi in un letto del blocco 27 dell’Haftling Revier, sezione chirurgica: operazione d’ascessi alla gamba. Pianse vedendomi… poi venne a dormire nella cuccetta vicino alla mia, era ridotto come un passerino implume. Egli mi faceva tutti i piccoli mestieri: fare il letto, cucire, aggiustare le calze rotte. Mi fabbricò anche un cuscino con la paglia e la juta. […]. Un giorno di fine aprile tutti i componenti del Blocco 8 (dov’era finito Luigi – n.d.r.) furono riportati a Mauthausen, in totale 650 uomini. Nessuno di questi è tornato a casa, ordine delle S.S. … nell’aprile del 1945 molti altri deportati, anche non inabili e non malati e non
del blocco 8 morirono a Gusen I … dove lavorava Caronni avvenne di peggio. Come si poteva salvare il buon Caronni quando nessuno di noi poteva far evitare questo peggio?». Il 23 aprile del 1945, quando già si sentivano gli echi dei cannoni americani da ovest e da est, quelli dell’Armata Rossa, Luigi Caronni, ridotto a 36 chili per lo sfinimento, con la
gamba destra piagata e medicata con bende fatte da carta per margarina, giornali, carta da pacchi, resti di stoffa e di biancheria, viene caricato sui tristemente noti “torpedoni azzurri”, con le tendine abbassate e il tubo di scappamento rientrante. Il veicolo compie il giro dell’Appelplatz e poi si ferma, si aprono le porte e, davanti agli occhi inorriditi dei
compagni, allineati sull’attenti, vengono scaricati i corpi esanimi. Sui registri del lager, e successivamente su altri documenti, venne scritto “Causa del decesso: debolezza della circolazione cardiaca … oppure… dissenteria”. Così a 39 anni si è conclusa la vita di Luigi.
Lascia un commento
Commenti
Stiamo all’erta perché questa cosa può tornare…